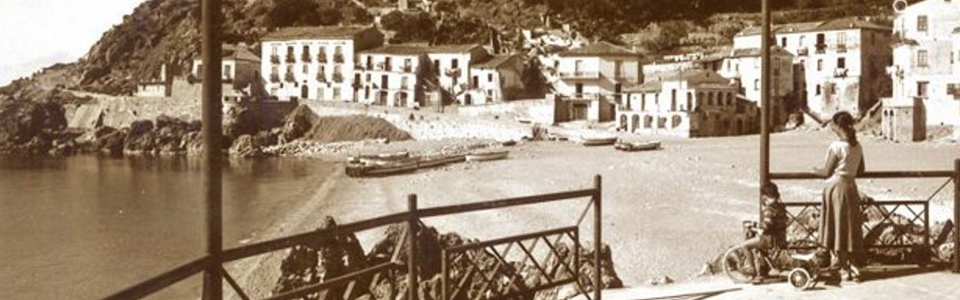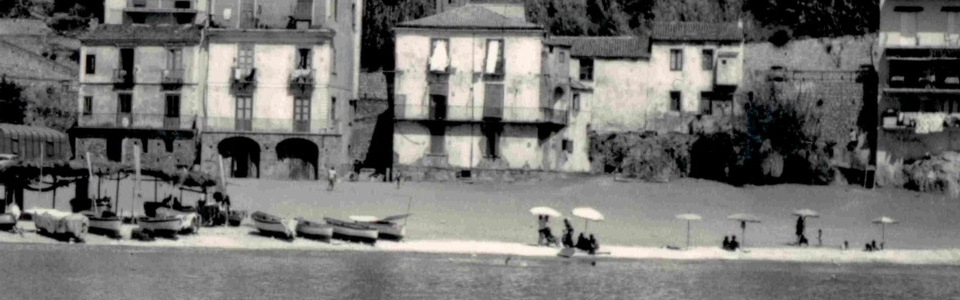L'idea
L’intento con cui nasce e, si spera, si svilupperà questo sito è quello di unire alle discrete facoltà delle nostre memorie personali la speranza di condividere, con chi ne sente come noi il bisogno, le esperienze passate, i ricordi e le testimonianze attraverso le quali porre argine alla inesorabile liquefazione della civiltà marinara di Maratea.
Fermare, anche solo attraverso il web, la fine dichiarata di un mondo che non c’è più e cercare di trasmettere nuovo impulso almeno al consolidamento di una memoria storica condivisa è il nostro immodesto obiettivo. Così, prendendo in prestito le parole di Guillaume Faye, potremmo dire che anche nella nostra società “l’uomo si è via via snaturato, perdendo il contatto con il mondo fisico, con il fuori-di-sé e con sé-stesso, appare sempre più un universo senza storia, senza radici, economicista ed anonimo, in seno al quale relazioni astratte, contrattuali, calcolatrici civiltà costituiscono i legami viventi, affettivi, storici, politici che fondano i popoli”. Per questo il recupero di uno “spirito arcaico, cioè premoderno, …che restauri valori ancestrali, quelli delle società di ordine(i)” è elemento fondamentale per iniziare la sfida per la conquista di quel futuro altrimenti precluso alla speranza dalla palude sociale che ci attanaglia.
E noi, pur consapevoli dell’inarrestabile quanto rapido evaporare di quel mondo di relazioni che trasmetteva oralmente i valori e il sapere, vogliamo offrire il nostro contributo a salvare il salvabile di quella civiltà marinara che, almeno fino a metà anni ’70, si è tramandata da secoli. Non siamo sicuri che le prossime generazioni di portaioli avranno in dote la conoscenza dei luoghi, la padronanza di un dialetto marinaresco ricco di termini e significati, la dimistichezza in mestieri ormai in disuso. Né siamo sicuri che fra venti, trent’anni, scomparsi i testimoni diretti di tante storie, un nome, un luogo, possa suscitare un ricordo, un pensiero a come eravamo e, soprattutto, chi eravamo; ma per capire dove possiamo andare è necessario sapere chi siamo stati e comparare questo con ciò che siamo adesso e quello che desideriamo essere.
Quindi solo se non consideriamo la Tradizione come una venerabile reliquia e la memoria storica come mero esercizio mnemonico ed operiamo attivamente quella forma di resistenza collettiva alla morte propria del tramandare, possiamo dire di non appartenere a quella generazione a cui Pessoa notò di appartenere: “generazione che ha perduto tutto il rispetto per il passato ed ogni credenza o speranza nel futuro. Viviamo perciò il presente con la fame e le ansietà di chi non ha altra casa.”
Ecco, allora, l’obiettivo di queste pagine: lasciare aperta una porta, la porta di quel fondaco tante volte varcata in gioventù, da cui si entrava in un mondo fatto di fatica e ingegno, sudore e vàsuli chiatràti e ùmmiti.

Le donne dei marinai
Le donne dei pescatori erano dedite a molteplici attività oltre quella, prevalente, della cura dei figli e della casa. Fra queste, quella della vendita del pesce pescato dai marinai del porto era sicuramente la più impegnativa; sicché tutti i giorni, in cui le condizioni del tempo consentivano agli uomini di andare a pesca dedicandosi ai vari “mestieri” (lambara, rizzi i funnu, coffe, scavicheddu, ecc.) a loro toccava un gravoso compito. Quando, ad esempio, i pescatori tornavano dalla lambara, Marina (moglie di Biasineddu), Luisa (moglie di Cilarduzzu ), Tresina ì Sceru (madre di Luisa), Maria Felice Iannini (detta Filici à surda) e altre donne di Maratea paese, si portavano presso le barche chiedendo al capopesca, per esempio zù Monicu, una o più cassette di alici (vedi documenti nella sezione pesca “la lambara”) in funzione di quanto pensassero di smerciarne in giornata. Il quantitativo di pesce acquistato non veniva pagato seduta stante, bensì annotato sui “libri contabili” del proprietario della lambara che sommava, giorno dopo giorno, quanto consegnato a ciascuna venditrice fino a quando, passata una settimana o dieci giorni, questa veniva chiamata a chiudere i conti.
‘U porcu
‘Na via ‘i gliànne:
“benedìca quantu si’ granne!”
Tagliacàpu ti và truvènnu
e ‘a caudàra sta ggià vuddénnu.
Scinni porcu fricàtu
jett’ ‘u sangu ‘nta ‘nu catu;
craje si’ sanguinàcciu
e ‘nvitàmu a Biasi ‘u pacciu.
Pedi jaccàti e ùgna russi
ncoppa ‘a scala d’ ‘a posta;
‘ncélu i guizzi da lu mussu
e ‘na camiàta senza sosta.
Mo ca ‘a zimma è luntàna
Sulu sangu int’a chiàna.
Ngi po sulu ‘na gran lama
prusciutti, capucòddi e assai salàm’.
una via di ghiande:
“benedica quanto sei grande!”
Tagliacàpu ti và cercando
e la caldaia sta gia bollendo.
Scendi porco spacciato
getta il sangue in un secchio;
domani sei sanguinaccio
e invitiamo Biasi il pazzo.
Piedi spaccati e unghia rosse
sulla scala della posta;
in cielo i grugniti dal muso
e un pasturare senza sosta.
adesso che il porcile è lontano
Solo sangue nella piana.
serve solo una gran lama
prosciutti capicolli e assai salami.
‘A cannìsta
Putìa maje jìnghi
‘i lacrimi ‘na cannìsta?
Eppùru, china d’acqua salata
t’ ‘a purtèvi.
Ériti l’acqua ‘i chiddu mari ammuccìatu,
quannu quetu, quannu ‘ndiavulàtu,
ca purtàva ‘na micciùna ‘int’ ‘u cori.
Nenti pozzu fa’
si ‘int’ ‘a cannìsta
ngi truvèsti sulu ‘u sali…
E nnenti ngi putìvi lla cannìsta
a ti stipà ‘nu mari sempi ‘n vista.
Potevo mai riempire
di lacrime una cesta?
eppure piena d’acqua salata
te la portai.
era l’acqua di quel mare nascosto,
quando quieto,quando agitato,
che portavo di nascosto nel cuore.
Niente posso fare’
se nella cesta
ci trovasti solo il sale…
E nulla potè la cesta
a conservarti un mare sempre in vista.
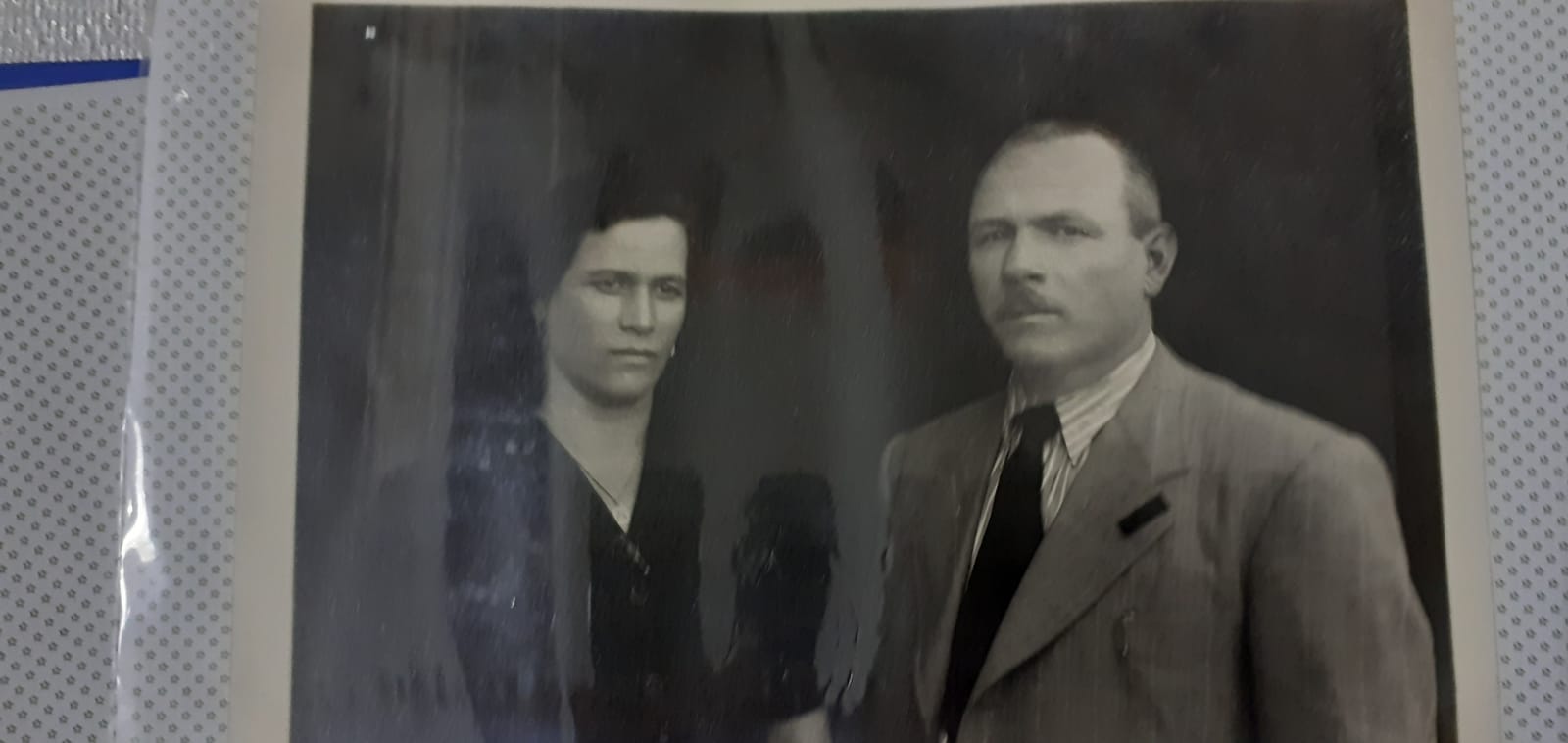
Zù Pascàli
Papà e mamma nn’anu sempi dittu
ca senza ‘i te
‘a fami s’avèriti pigliàtu
puru a lloru.
E nnuje ca nonn amu maje canusciùtu nonni
cu tte,
àmu avùtu ‘a ciorta
‘i nn’ avì tre.
Papà e mamma ci hanno sempre detto
che senza di te
la fame si serebbe preso
pure loro.
E noi che non abbiamo mai conosciuto i nonni maschi
con te,
abbiamo avuto la fortuna
di averne tre.
Zù Nicola
Quannu t’addummannàvinu l’ura
e tu, ‘ngoddu ‘u vistìtu bbonu,
da ‘int’ ‘a sacchetta
cacciàvisi ‘u dirròggiu
cu ‘a catinèdda d’oru,
avìsi l’ura bbona pi tutti.
Ma quannu vinìviti
‘u mumèntu tùu
ti truvèviti appisuliàtu
e nonn’ appìsti l’aggiu ‘i sapì,
da chidda cipùdda,
si chidda èriti l’ura
justa pi tte.
Quando ti chiedevano l’ora
e tu indossando il vestito buono
da dentro al taschino
cacciavi l’orologio
con la catenina d’oro,
avevi l’ora buona per tutti.
Ma quando venne
il tuo momento
ti trovò appisolato
e non avesti la possibilità di sapere
da quella cipolla,
se quella era l’ora
giusta per te.